| L'ANGOLO DEL VETERINARIO
La leishmaniosi del cane,
sintomatologia,
Questa malattia rappresenta un grosso problema
soprattuno nelle regioni meridionali.
|
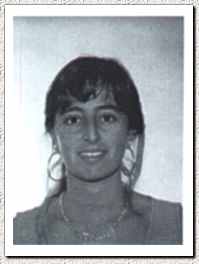 |
||
| Leishmaniosi del cone argomento scottante del quale quotidianamente
si parla sia negli ambienti cinofili che in quelli profani, spesso facendo
solo una grande confusione. Sono molti, infatti coloro che hanno una conoscenza
superficiale ed anche errata della malattia. II grande interesse per la
Leishmaniosi del cane deriva dal fatto che questa malattia è una
"zoonosi", cioè trasmissibile dall'animale (cane) all'uomo. II ruolo
di serbatoio di Leishmanie può essere svolto, oltre che dal cane,
anche dalle volpi e dai roditori. In Italia le zone ove la malattia risulta
"endemica" sono quelle meridionali ed insulari, molto frequentemente si
riscontra nelle regioni del centro (Argentario) e soprattutto del nord
(Liguria). La maiattia può comparire anche in regioni ancora indenni
a seguito dello spostamento dei cani sul territorio nazionale (cani da
caccia, commercio dei cani, viaggi turistici con i cani), semprechè
trovi il flebotomo adatto a trasmettere la "Leishmania". Le Leishmanie
sono dei protozoi che nei vertebrati (cani, volpi, uomo) si presentano
nella tipica forma a "Leishmania" (ovoidale, priva di flagello) mentre
nelltospite invertebrato (flebotomo) hanno forma a `'leptomonas" (fusiforme
e munita di flagello). La trasmissione della malaHia avviene tramite un
"agente vettore attivo" rappresentato da alcune specie di flebotomi, insetti
simili alle zanzare. Infatti, solo alcune specie di flebotomi (Perniciosus,
perfilievi, ecc...) sono in grado di trasmettere le Leishmanie. Questi
insetti hanno abitudini notturne e solo le femmine sono ematofaghe, durante
l'ovogenesi. Si muovono solo nelle sere senza vento e sono attratti dalla
luce. All'atto di fare il pasto di sangue sul cane il flebotomo ingerisce
anche molte cellule parassitate (istiociti) presenti nella cute. Nell'organismo
del flebotomo le Leishmanie si moltiplicano prendendo l'aspeho a Leptomonas,
cioè quello di protozoo flagellato. Non è mai stata dimostrata
la trasmissione della malattia attraverso altri insetti ematofagi (zecche,
pulci, tafani). Pertanto, il rapporto Leishmania-uomo si realizza solo
per il tramite del flebotomo. L'infezione va vista in questa seguenza:
cane-flebotomo-uomo (cosl come cane-flebotomo-cane). Le Leishmania patogena
per l'uomo sono: Leishmania Tropica che provoca il cosidetto"Bottone d'Oriente"
(forma esclusivamente cutanea); Leishmania Donovani, per il Kala Azar (forma
viscerale); Leishmania Infatum per il Kala Azar del Mediterraneo. Per il
cane la cosa è più complessa, poichè nell'area
di diffusione della malattia nel cane, si verificano nell'uomo casi di BoHone d'Oriente e casi di Leishmania Viscerale. In Italia non si riscontra la forma cutanea riferibile al Bottone d'Oriente come si osserva invece in Iran, Afghanistan ed in altri paesi asiatici. Le lesioni cutanee riscontrate nel cane in Italia fanno parte dell'infezione generalizzata, nel senso che rappresentano l'espressione sintomatologica cutanea di un processo che coinvolge l'intero organismo, con presenza di Leishmanie nel midollo osseo, nella milza, nei linfonodi ed in genere nelle cellule del Sistema Reticolo Istiocitario (S. R.l.). In Italia l'agente patogeno per il cane è Leishmania Infantum. Riguardo l'agente veHore aHivo della malaHia (flebotomo) possiamo dire che ha un ciclo riproduttivo che può andare dai 35 ai 60 gg. a seconda delle condizioni di temperatura ambientale e della possibilità di nutrizione delle larve. In genere i flebotomi vivono nei terreni ricchi di detriti organici è sufficientemente umidi. La scelta della vittima da pungere non è sempre facile: anche le femmine delle specie più antropofile possono non accorgersi della presenza di una persona se questa si trova a più di 10 mt. di distanza. I luoghi di riposo preferiti dai flebotomi li dividono in specie "silvestri" che si rifugiano nei tronchi d'albero, tra le fessure della corteccia e nelle cavità della pianta; e specie "peridomestiche" che riposano per lo più sui muri delle abitozioni e nelle ore più calde della giornata si rifugiano nelle fessure e nelle crepe degli stessi, e penetrano all'interno dell'ambiente domestico per nutrirsi (endofaghi), fermandovisi talvolta anche durante la digestione (endofili). Dott. Valeria Monfrini Berretta
|
|||
last modified04-12-98 |
 |